|
I CLASSICI
Umberto Galimberti |
Si leggono sempre meno i
classici nelle nostre scuole, nelle nostre case, e così la
nostra anima più non conosce le parole per nominare l'amore,
per quel tanto che ha di enigmatico e buio, il dolore nelle
sue espressioni che vanno dalla malinconia al mondo chiuso e
opprimente dell'angoscia, la gioia nelle vertigini della sua
esaltazione, la noia nel suo spessore denso e opaco. Cosa
comporta questa afasia? Che i sentimenti attraversano
l'anima senza che noi si possa dialogare con loro. Pure
sensazioni che ci afferrano, dilatando o comprimendo la
nostra vita, senza lasciare una traccia, un'indicazione per
costruire una geografia del nostro cuore, in cui potersi
riconoscere senza doverci temere. Eh sì, perché fa paura
quando ciò che si prova è senza nome e il suo percorso è
imperscrutabile. I classici, che sono tali perché hanno
saputo cogliere le metafore di base dell'umano, ci insegnano
i nomi con cui noi possiamo chiamare e richiamare i nostri
sentimenti, dialogare con loro, attutire la loro violenza,
assecondare la loro dolcezza, accudire la loro incertezza,
ribaltarli persino, per scoprire quanto odio c'è sotto il
nostro amore, quanta aggressività sotto la nostra cortesia,
quanto disprezzo nasconde la nostra lode, quanto ignobile
vizio sottende la nostra ostinata virtù. Perché i meandri
del cuore sono inaccessibili alla linearità con cui la
nostra ragione articola e separa il bene dal male, il vero
dal falso, il giusto dall'ingiusto, perché tutto ciò che la
ragione distingue il cuore lo fonde e lo con-fonde, per cui
il vocabolario della ragione a nulla serve per orientarci
nei percorsi segreti e nascosti del cuore. Il trionfo della
razionalità, nell'età della tecnica, distribuisce nomi
precisi dal significato univoco e non confondibile. Anzi ai
nomi, che ancora portano con sé troppa approssimazione,
tende a preferire i numeri, soprattutto i numeri primi con
cui si costruiscono
i programmi dei nostri computer. Per questo linguaggio, oggi
egemone, la domanda di Leopardi: "Dimmi che fai tu Luna in
ciel?" è pura insensatezza. Eppure sarà capitato a tutti
noi, in una notte ancora lontana dalla luce dell'alba,
chiedere alla luna se non proprio che cosa ci fa in cielo,
cosa ci facciamo noi sulla Terra. E per questo genere di
domande non c'è linguaggio della ragione che sia
all'altezza. Qui bisogna scendere nel linguaggio del cuore.
Ma come facciamo se non sappiamo nulla dell'Inferno e del
Paradiso perché conosciamo Dante solo perché ci sono delle
vie a lui dedicate? Come possiamo reggere il dolore e capire
che la malattia è l'ultimo effetto della mancanza d'amore se
non siamo mai saliti al sanatorio che Thomas Mann descrive
ne La montagna incantata? Come gettare un'occhiata e
scoprire qualcosa che passa sotto la soglia della nostra
coscienza se non abbiamo mai incontrato Dostoevskij quando,
spietatamente e senza infingimenti, scrive le sue Memorie
dal sottosuolo.
Che ne sappiamo della "nausea" se Sartre è sparito dalle
nostre librerie perché nessuno più lo legge? Che ne sappiamo
dello "straniero" e come facciamo a discutere di immigrati,
di integrazione e di espulsione se mai abbiamo sperimentato
la condizione di straniero e neppure ci siamo fatti aiutare
da uno dei capolavori di Camus? Davvero possiamo capire
qualcosa della miseria senza aver letto I Miserabili di
Victor Hugo? Oppure qualcosa della guerra e della pace, per
quel tanto di indistinto e indiscernibile queste due parole,
apparentemente opposte, significano, se non abbiamo aperto
neppure una pagina del capolavoro di Lev Tolstoj?
Fin qui i classici della letteratura che ci fanno conoscere
quel che passa nella nostra anima, semmai la cosa ancora ci
riguarda e ancora non siamo giunti a temere noi stessi più
di qualsiasi altra cosa. Accanto a loro ci sono i classici
della filosofia, utilissimi per correggere le nostre idee.
Infatti, oltre ai disagi determinati dalle contorsioni della
nostra anima, ci sono i disagi determinati dalla confusione
delle idee che condizionano la nostra esistenza,
costringendola in una coazione dove le è dato solo di
ripetere se stessa senza vie di scampo. Ci sono infatti idee
malate che ci fanno smarrire la giusta misura, come le idee
del potere, del successo, dell'apparire, altre che
affliggono l'anima come l'idea di colpevolezza, di peccato,
a retaggio di una cultura religiosa mal intesa. Ci sono poi
idee sconosciute come quelle di "tolleranza" su cui Locke ha
fatto fondamentali riflessioni, o di "rispetto" a cui Kant
ha dedicato pagine elevate. Perché non conoscere poi la
differenza che corre tra la giustizia e quel suo correttivo
che è l'equità come Aristotele ce la illustra, o le profonde
riflessioni sull'amore come Platone ce
le espone nel Simposio. E sulla verità e sulla fede, oggi in
rotta di collisione, perché non leggere le pagine di Jaspers
che ci fa capire come una dimensione non sia compatibile con
l'altra?
Si obietta che la filosofia è difficile. Non è vero. E in
ogni caso sempre meno difficile della difficoltà e della
resistenza che tutti noi, chi più chi meno, opponiamo alla
correzione delle nostre idee, al loro cambiamento, da cui,
in una misura che neppure sospettiamo, dipende il
cambiamento della nostra vita, la sua capacità di rinnovarsi
e di non appiattirsi nella monotonia della ripetizione o
affogare nelle semplificazioni dell'ignoranza che sembra non
abbia mai dato strumenti particolarmente idonei per vivere.
Il giorno in cui i classici diverranno archeologia, reperti
buoni per i musei, seppelliti, quando ancora si dovessero
trovare nelle librerie, sotto le montagne di copie
dell'ultimo best-seller (espressione questa che serve a
segnalare quali sono i peggiori libri in circolazione),
allora l'umanità sarà giunta all'ultimo scalino
del suo degrado, e quei pochi individui che ancora leggono
quei libri dalle copertine colorate con i titoli in rilievo,
ben poco si distingueranno dai loro simili che non leggono e
di cui c'è solo da augurarsi che non aprano mai la bocca né
in pubblico per non mostrare, insipienti, il vuoto della
loro mente, né nell'intimità per non far trasparire, quando
non una disarmante banalità, l'afasia del loro cuore
insipido, incapace di dar tono, senso ed emozione persino
alle movenze standard del loro corpo.
da Repubblica
| |
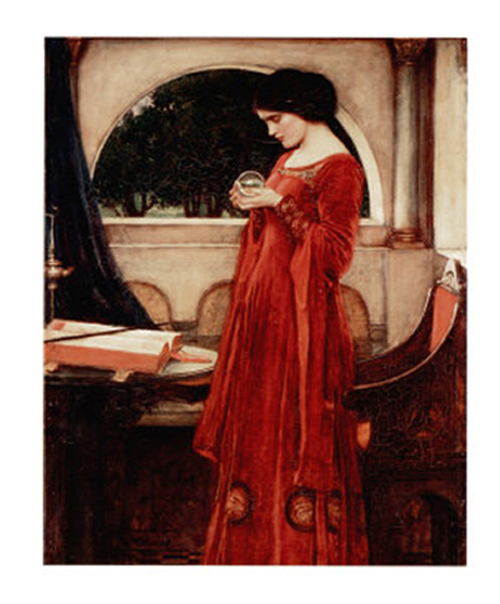
E.B.Jones
|
|
|